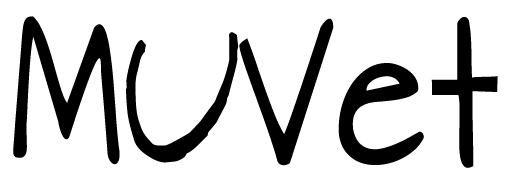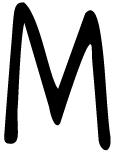A fine novembre ho partecipato a una settimana di ricerca coreografica a Berna, nell’ambito del progetto europeo Moving Beyond Inclusion (di Creative Europe) di cui è partner l’Italia, insieme a Svizzera, Svezia, Germania, Croazia e Inghilterra. MBI, come recita il sito dedicato, è un programma di “creative and professional exchanges, choreographic research, symposia, performances and skills development for people working in dance [..] At the heart of the project is the fundamental belief that working inclusively produces more exciting, more excellent artistic work for audiences to enjoy”.
A fine novembre ho partecipato a una settimana di ricerca coreografica a Berna, nell’ambito del progetto europeo Moving Beyond Inclusion (di Creative Europe) di cui è partner l’Italia, insieme a Svizzera, Svezia, Germania, Croazia e Inghilterra. MBI, come recita il sito dedicato, è un programma di “creative and professional exchanges, choreographic research, symposia, performances and skills development for people working in dance [..] At the heart of the project is the fundamental belief that working inclusively produces more exciting, more excellent artistic work for audiences to enjoy”.
L’associazione MUVet – che si caratterizza per i suoi percorsi di danza senza barriere, come le Pratiche condivise – è stata coinvolta dal Festival Oriente Occidente (partner italiano del progetto) fin dall’inizio di MBI che, partito nel luglio 2016, si concluderà a primavera 2018, lasciando una scia di importanti azioni e riflessioni per la ricerca, la formazione e la performance di danza contemporanea che promuove la professionalizzazione di artisti disabili e non, adottando una prospettiva inclusiva.

Dampf Zentrale – sede della residenza artistica a Berna
Berna è una delle varie tappe di MBI che vorrei riassumere perché esempio positivo di residenza creativa, replicabile in una formula simile sul nostro territorio, anche in altri contesti di alta formazione. Si è trattato, infatti, di un percorso artistico che ha coinvolto un gruppo di danzatori abili e disabili, provenienti da diverse parti del mondo, ognuno con la propria cultura, la propria estetica, la propria abilità, coordinati da un coreografo e la sua assistente, e con il contributo di artisti e studiosi, invitati a offrire punti di vista e pratiche. Un processo di apprendimento cooperativo e co-costruito, dunque, come quelli di cui parla la pedagogia attiva, in riferimento a contesti educativi accoglienti e inclusivi (come si auspica possano essere le scuole) che tengono conto dei “bisogni speciali” dell’Altro, creando cornici aperte e flessibili, dove molteplici sguardi e voci compartecipano, alla pari.
Riprendendo le parole del filosofo Byung-Chul Han, che sottolinea la necessità di resistere alla “violenza dell’uguale” con l’ospitalità, ovvero l’accoglienza delle singolarità e l’apertura al confronto e al conflitto necessari: solo la “gentilezza è in grado di riconoscere l’Altro nella sua alterità e dargli il benvenuto” e questa gentilezza è libertà e, da un punto di vista estetico, è bellezza (cfr. L’espulsione dell’altro, p. 28). Tanta bellezza è emersa in queste giornate di studio e ricerca e nella presentazione pubblica del processo, avvenuta in chiusura.
Ma andiamo con ordine e dividiamo in paragrafi il racconto, così da poter seguire un ragionamento che affonda in una pratica, ma si interroga anche sulle idee di corporeità dell’oggi.

Un momento delle prove con Alessandro Schiattarella
_a frame of opportunities_
Il Choreographic Lab organizzato dalla compagnia svizzera BewegGrund di Susanne Schneider è il proseguo di una ricerca già avviata nel 2016 (in Sud Africa, con la compagnia Unmute Dance Company) dall’artista Alessandro Schiattarella, che ha coinvolto (con una selezione su candidatura) 10 danzatori con disabilità fisica, sensoriale e di apprendimento, e una danzatrice abile, in due settimane di residenza.
Partecipare agli ultimi giorni di creazione è stata per me un’occasione unica di confronto e di sperimentazione. Conoscere in azione gli artisti coinvolti mi ha dato la conferma che l’arte è davvero capace di concretizzare utopie. La logica dello scambio e delle relazioni alla pari, senza gerarchie, della gentilezza e dell’inclusione sono un ideale a cui mirare, realmente. E’ stato chiaro che la forma che questa aspirazione deve prendere si modella sulle persone che si incontrano e le danno letteralmente corpo, agendo in una comunità che fa nascere legami forti e duraturi, che attraversano i continenti.
Ines Coronado (Perù); Alice Giuliani e Giuseppe Comuniello (Italia); Iñigo Martínez Sagastizábal (Spagna); Laila White (UK & Spain); Katja Ruesch, Samira Boesch, Esther Kunz (Svizzera); Nadine McKenzie (Sud Africa); Outi Elena Valanto (Finlandia) e Pierre Geagea (Libano) hanno trovato questa forma, guidati da Alessandro, Kihako Narisawa (assistente del coreografo) e sostenuti da Susanne; grazie anche agli interventi di Annalisa Piccirillo (ricercatrice italiana) e Claire Cunningham (artista disabile scozzese).
_relazione e vicinanza, sul terreno comune del corpo_
Come osservatrice “ai bordi del processo”, mi sono accostata alla sperimentazione assistendo da vicino (e talvolta da dentro) ai processi di traduzione – del linguaggio verbale e corporeo – che in un gruppo molto misto si sono inevitabilmente attivati. Per comprendere le indicazioni e le riflessioni si utilizzava, oltre all’inglese, l’italiano, lo spagnolo, la lingua dei segni per non udenti e la tattilità per i non vedenti. Obiettivo comune era creare un territorio di scambio di linguaggi ed esperienze corporee sì diverse, ma molto prossime e risonanti, mosse dal desiderio di esserci ed essere con l’altro di ognuno, di collaborare al medesimo processo creativo, finalizzato a una piccola presentazione pubblica che ha previsto anche un partecipato dibattito con gli spettatori.
Se l’estraneità “si manifesta come mancanza di parole” – dice ancora Byung-Chul Han – il problema della parola mancata e della distanza si è risolto qui con una “Babele di voci” che si incontravano e si scambiavano lemmi e variazioni di senso in lingue diverse. L’alterità è stata così celebrata nella vicinanza e nelle relazioni faccia a faccia, corpo a corpo. La differenza tra Noi/Loro annullata da un ambiente accogliente, dove l’agio prevaleva sull’ansia di dimostrare qualcosa; l’individuo con le sue peculiarità qui è al centro, con un obiettivo comune da condividere, verso il quale tendere assieme. I pregiudizi e le aspettative rispetto al “cosa posso fare” o “cosa l’altro può fare” sono stati esplicitati e discussi, un cambio di prospettive sperimentato in vari modi.
Ogni giornata era così articolata: un training esplorativo, guidato da Kihako dava inizio ai lavori, mentre nel pomeriggio ci si concentrava sulla composizione, coordinata da Alessandro. Le proposte del mattino erano principalmente basate sul contatto e la relazione: “studi di funzionamento” del corpo dell’altro e delle possibilità di condivisione di brevi pattern esplorativi. Questi momenti hanno creato un clima rilassato, permettendo in breve tempo una conoscenza profonda del gruppo, passando dal corpo e dalla sua funzionalità, dal peso e dalla modulazione della pressione sulla superficie corporea, o dall’uso di ausili come stampelle o carrozzine. Ciascun danzatore ha avuto modo di esprimere necessità, desideri, esigenze personali, mettendo in circolo informazioni preziose, subito esplicite e chiare per tutti.
_chain reaction e inclusione_

Un esempio di reazione a catena con gli oggetti
Il lavoro di composizione ruotava attorno all’idea proposta da Alessandro, assunta a tema della residenza: la chain reation (o reazione a catena), un meccanismo semplice, alla base dell’esperienza quotidiana di tutti, la successione degli eventi per cui da un accadimento ne scaturisce un altro, che ne genera un altro e così via. Per il coreografo una metafora capace di riassumere l’idea dell’inclusione, molto chiara nel video-stimolo da cui è partita la sua ricerca: “Der Lauf der Dinge” del 1987, film d’arte del duo svizzero Peter Fischli e David Weiss. Qui oggetti molto semplici sono concatenati e creano una coreografia che li pone sullo stesso piano di valore.
Il lavoro con gli oggetti è stato preambolo per un accurato studio sui meccanismi del corpo e dell’incontro con un altro. La metafora che richiama il quotidiano e le relazioni interpersonali è molto chiara, e gli stessi partecipanti affermano di aver pensato a quanto la proposta richiamasse un vissuto personale. Laila a tal proposito dice: “Tornare sui propri passi a volte per individuare dove mancava la connessione, dove non era stata ben compresa una parola, dove c’era un inghippo è ciò che abbiamo praticato in queste due settimane, dove diverse culture si sono incontrate e hanno scambiato informazioni, desideri, pratiche”. Nella vita è utile interrogarsi sul dove le connessioni non sono reali, o fanno un salto, o dove al contrario innescano una serie di eventi anche minimi che possono portare a delle conseguenze molto gravi.
Oltre a sequenze di gruppo e di coppia, dei brevi assoli hanno costituito il materiale di ricerca e studio. Ogni pezzo si può definire una distillato dello stile di movimento e della personalità dei singoli danzatori. Anche qui il tema della composizione è stato la reazione a catena. Essere leggibili è importante, per rendere chiari agli altri i propri meccanismi di connessione dei gesti.
_ voce, sguardi, prossimità_

La presentazione è avvenuta nella sala prove, troppo piccola però per contenere altre persone oltre agli interpreti. Il pubblico ha potuto assistere al materiale da uno spazio adiacente, ovvero dal foyer del Dampf Zentrale, grazie alle riprese effettuate con la telecamera di un telefonino e la trasmissione in diretta Skype del video.
Lo spazio dell’azione appare come un campo da gioco da cui si entra e si esce per giocare e si aspetta il proprio turno, osservando gli altri. La voce di Alice, che parla in italiano, amplificata da un microfono, commenta l’azione in corso, come una telecronaca, talvolta del suo movimento e delle sensazioni che prova, altre volte di ciò che accade a un altro, o al gruppo. Il commento vocale, descrittivo ma anche metaforico, è nato dalla necessità di rendere noto a Giuseppe (danzatore non vedente) lo svolgersi dell’azione. È poi diventato parte del processo drammaturgico e di una ricerca sul dire/agire il movimento, sostanziata dall’intervento di Claire Cunningham che ha proposto riflessioni molto acute e percorsi esplorativi mirati: “come dico il mio movimento”? Provo a descriverlo nell’esatto momento in cui lo compio, per fare esercizio di presenza e attivare così l’interesse di chi mi guarda. Se mi tengo costantemente occupato, la mia azione funzionale assumerà spessore e perderà i fronzoli della rappresentazione. “Se racconto il gesto prima di compierlo, faccio coreografia; se ne parlo subito dopo faccio critica” – ha segnalato.
Nel momento della presentazione, l’invito a prendere parte alla catena di azioni e reazioni si rivolge implicitamente al pubblico, che – ammette – si sente chiamato in causa e un po’ frustrato dal non poter seguire l’azione da vicino, ma solo tramite l’occhio della telecamera, indirizzata da Kihako sui dettagli dei gesti concatenati. Un ideale proseguo del lavoro potrebbe avere questo sotto-testo: “Prendere parte a un sistema complesso che include tutti, nello stesso modo, con lo stesso valore. Ogni momento è importante e innesca il passaggio successivo che mantiene in equilibrio tutto”. Se la tendenza oggi è quella dello “svanire dell’essere di fronte [che] rende il mondo privo di voce e privo di sguardo” (Han, p.75), una necessità che emerge è quella di partecipare, di essere con e dare corpo a voce e sguardi di ognuno, di ascoltarsi e ascoltare.
Il pubblico è un po’ escluso di fatto dal processo, è voyeur suo malgrado e spettatore prossimo e desideroso di inserirsi in una catena di azioni, almeno per qualche fugace istante. I danzatori mostrano solo il lato dell’azione che scelgono di mostrare ed escono a contatto con gli spettatori per un brevissimo tempo. È come se segnalassero una distanza, che però è necessario colmare! Quello che rimane nell’aria infatti, dopo la presentazione, è il desiderio di prossimità e contatto, che è scattato da entrambe le parti. “Il mondo è sguardo. Il mondo oggi si presenta come un pascolo per l’occhio, che cerca di piacerci” (Han, p. 62). Lo sguardo rivolto all’altro è sempre meno accompagnato dalla sua presenza fisica. Il privilegio della danza – che implica sensorialità, voluttà, seduzione – viene qui fatto desiderare… diventa qualcosa che vorremmo avere, ma non ci viene data.
_ una conclusione aperta_
Per me, come in una reazione a catena, si può riconoscere una successione di fasi nella performance, come nel processo che ha portato a presentarla: dallo studio del corpo e dei suoi meccanismi, della pura tecnica, si è passati a un linguaggio della percezione, a una maggiore consapevolezza delle sensazioni e della presenza a se stessi e all’altro, per ragionare con il pubblico sulla condivisione e sul livello di coinvolgimento dell’occhio dello spettatore e di tutto il suo corpo, con sentimenti, visioni, pregiudizi… Da uno studio sui meccanismi, sulla tecnica e il dettaglio, si è cioè passati al sentire e al desiderio di trasmettere se stessi e il proprio modo di essere nella danza e nel mondo e di escogitare un modo per rifletterne col pubblico.
Il fatto che il gruppo di danzatori fosse quasi interamente composto da persone con disabilità non ha fatto molta differenza per gli spettatori – ha affermato un signore nella conversazione finale. Ciò a mio avviso rivela quanto uno sguardo nuovo sul danzatore disabile si stia educando. La professionalità degli interpreti permette questo scatto in avanti!
Vorrei concludere con una nota sull’Italia a tal proposito. Tra il grande pubblico della danza italiano serpeggia ancora il virus del pietismo. Occorrerebbe che sempre più esperienze professionali – come quella appena raccontata – con artisti disabili di alto livello, venissero presentate in scena, per andare oltre la visione di una “danza per tutti” intesa solo come modalità di intrattenimento e socializzazione, condivisione di tempi e spazi di espressione. La danza è inclusiva di per sé oggi: è ricerca, formazione e performance atta a modificare un pensiero univoco e normalizzante, oltre le aspettative e il già noto. Ci educa alla cultura della diversità come risorsa e opportunità di crescita personale e sociale, ci educa alla trasformazione del sè e all’invenzione, spingendo verso il cambiamento della società tutta.

Grazie ai magnifici danzatori che ho incontrato! E in particolare a Susanne e Alessandro per avermi invitato a Berna, a curiosare all’interno del loro lavoro e della loro vita lì. Grazie anche ad Anna di Oriente Occidente che facilita questi scambi! E a Giulia, che è venuta con me…